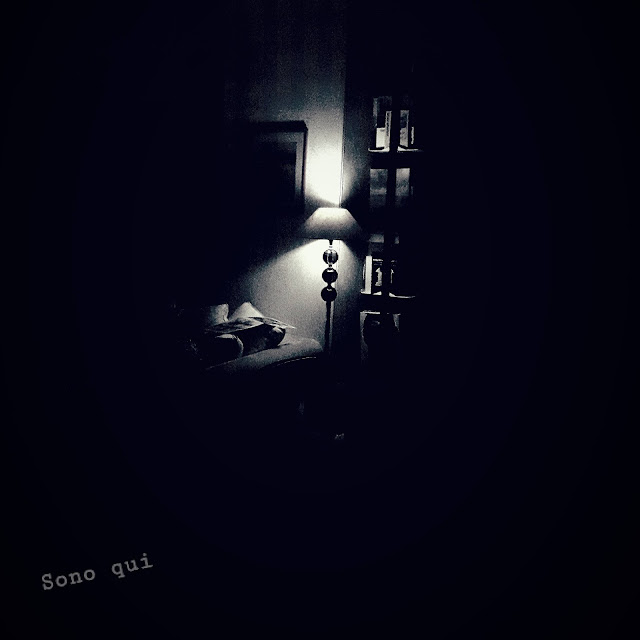- Paola Foggetti

- 5 ago 2020
- Tempo di lettura: 3 min

Da sempre l'attività onirica ha interessato poeti, filosofi e scienziati. Il fascino del mondo dei sogni, con i suoi misteri, attrae culture e discipline diverse. Da un punto di neuropsicofisiologico l'attività onirica, specifica del sonno REM, riguarda quella fase del sonno, generalmente rappresentata nella seconda parte della notte, in cui si presenta una quasi completa perdita di tono della muscolatura volontaria e durante la quale si verifica l’attività onirica più intensa. Oggi sappiamo che la funzione dei sogni è proprio quella di elaborare le emozioni, le situazioni complesse, gli eventi negativi, le preoccupazioni e i ricordi per ognuno di noi significativi. Il sogno, quindi, agisce come una terapia notturna.
Questa primavera ci siamo trovati a vivere un'esperienza unica per la nostra epoca, la pandemia della SARS-CoVid-2. Gli effetti di questa malattia sono stati, per molti pazienti, drammatici. Inoltre la paura di infettarsi e la difficoltà a gestire il lockdown hanno alterato in molte persone alcuni sistemi biologici. Tra questi il ciclo sonno veglia è stato particolarmente colpito e si sono presentati maggiori disturbi del sonno.
Studi neuropsicologici evidenziano, da anni, che durante la fase REM, il nostro cervello si attiva al fine di gestire le emozioni intense, soprattutto quelle negative.
Recenti studi internazionali hanno evidenziato dutante e dopo il lockdown un aumento significativo dei disturbi del sonno (definite Parasonnie) in fase REM, quei disturbi del sonno maggiormente presenti anche negli stati post traumatici. https://link.springer.com/article/10.1007/s00415-020-10056-6
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-pandemic-is-giving-people-vivid-unusual-dreams-here-is-why/ https://www.kcl.ac.uk/news/the-three-groups-reacting-to-life-under-lockdown https://rebecca-renner.com/ In breve, le Parasonnie del sonno REM sono : A) Il Disturbo Comportamentale in Sonno REM (REM SLEEP BEHAVIOR DISORDER – RBD) si contraddistingue per la perdita della fisiologica atonia muscolare. Per tale motivo, durante gli episodi, che si verificano più frequentemente nella seconda parte della notte, le persone presentano una eccessiva attività motoria, spesso caratterizzata da comportamenti bruschi (come urlare, tirare pugni e calci), in rapporto al contenuto dei loro sogni, i quali vengono riferiti, generalmente, a contenuto negativo; B) La Paralisi del Sonno. Durante questo disturbo, le persone, nonostante rimangano coscienti, hanno la percezione di non potersi muovere. Gli episodi si possono verificare durante la fase di addormentamento (“paralisi ipnagogiche”) o in seguito ad un risveglio (“paralisi ipnopompiche”). Possono essere accompagnate da allucinazioni uditive o visive e possono durare da pochi secondi a parecchi minuti, causando spesso intensa ansia nel soggetto che le vive; C) Gli Incubi Notturni . Consistono in sogni paurosi, a contenuto negativo, spesso di lunga durata; frequentemente tali sogni inducono il risveglio del soggetto che ne mantiene un vivido ricordo. Sono frequenti nei bambini oppure nei pazienti con “disturbo post-traumatico da stress”. Possono essere favoriti dalla febbre oppure dalla brusca sospensione di alcol o di farmaci che riducono il sonno REM. Da uno studio osservazionale della mia esperienza clinica on line, durante il lockdown il 30% dei pz (9 pazienti su 30) età media 32 anni, hanno presentato: - alterazioni del ciclo sonno veglia - aumento dell'attività motoria durante il sonno nella fase REM (Disturbo Comportamentale del sonno REM) - mentre il 10% ha avuto un maggior numero di episodi di sonnambulismo (non dovuti agli effetti collaterali di farmaci psicotropi).
Le evidenze cliniche e altre, che riguardano la popolazione generale, stanno confermando che la maggior parte delle persone durante l'emergenza Coronavirus ha sofferto di disturbi del sonno e anche la ripresa di un buon sonno, dopo il lockdown, non è stata facile